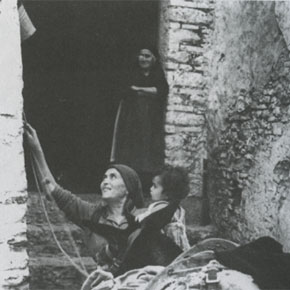
Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura Cinematografica, Gorizia, 19-28 luglio 2012
Quando l’arte si rivela scomoda
Il fascino del mezzo cinema non deriva solamente dalle storie e dai personaggi cui può magicamente dare vita, ma anche e forse più di tutto dal periodo storico che rappresenta. Ogni fattore di realizzazione di un film – budget, produzione, distribuzione, censura… – raffigura un sintomo dell’epoca in cui esso si è sviluppato, cosicché anche l’iter dell’opera stessa può diventare un tassello di conoscenza e di memoria storica.
Come noi siamo stati ammaliati dalle rocambolesche vicende di molti film (pensiamo ad esempio a quella di Metropolis), così lo è stato Stefano Missio per il documentario di Joris Ivens, L’Italia non è un paese povero, a tal punto da dare vita egli stesso nel 1997 al documentario (proiettato durante il 31° Premio Amidei) Quando l’Italia non era un paese povero, sulla cosiddetta “scomparsa” della copia originale del primo.
Nel lontano 1959, il presidente dell’Eni Enrico Mattei affida al maestro olandese, con scopi chiaramente propagandistici, la produzione di un documentario sullo sviluppo dell’industria petrolifera italiana, con la collaborazione dei fratelli Taviani, di Valentino Orsini e di Tinto Brass. Si tratta di una fotografia particolarmente cruda e severa dell’Italia dell’epoca, un paese contadino che si sta concedendo alla modernizzazione, ma in cui contemporaneamente si denuncia ancora una grande povertà. Il film è suddiviso in tre capitoli: Fuochi della val Padana e Due città diretti da Ivens, e Appuntamento a Gela dei Taviani.
Dopo molti mesi di lavorazione accurata e puntigliosa, la RAI (a causa di palesi influenze politiche) si rifiuta di trasmettere integralmente il film, mandandolo infine in onda censurato sotto il titolo di Frammenti di Ivens. Un infuriato Ivens, abbandonato proprio da quel sostegno politico che gli commissionò il film, decide così di trafugarlo e, con l’aiuto di Brass, la pellicola raggiunge Parigi.
“Ho chiamato tutti i testimoni dell’epoca per raccontare un film che non si è mai visto”, spiega Missio; così, come un moderno Harrison Ford alla ricerca del – si può proprio dire – tesoro perduto, tramite testimonianze, ricerche, analisi, ripercorre la vita dell’opera, in modo da poterle ridare quell’onore che spetta non solo alla memoria storica italiana, ma anche ad una firma del più grande documentarista della storia del cinema.
Se in quel 1997 Stefano Missio si fosse autoeletto difensore ufficiale delle pellicole “misteriosamente” perdute o censurate, diciassette anni dopo avrebbe ancora molto lavoro da fare.