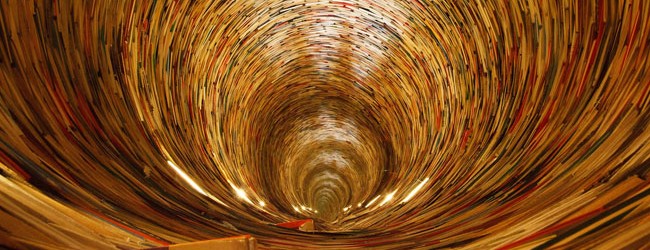
Gli studiosi – compreso chi scrive – hanno trascorso gli anni Novanta a discutere delle nuove configurazioni cinematografiche, di come il postmoderno stava mescolando tutto e il contrario di tutto, il basso e l’alto, la destra e la sinistra, e di come il cinema stava perdendo la classicità in nome di racconti più modulari, aperti, “critici”.
I blockbuster degli anni duemila avevano confermato storie affastellate e farraginose, molto spesso pensate per un pubblico giovanile che in sala fa anche altro (parlare al cellulare, chiacchierare con gli amici, andare al bar per comprare altro cibo, etc.), quindi con pause, buchi, strategie di recupero dello spettatore durante le due ore (la saga dei Caraibi, la saga del maghetto e altri franchise funzionano proprio così). Da qualche tempo, complice la potenza devastante della serialità televisiva americana (e non solo), il cinema ha cominciato a sua volta a ripensarsi.  Se vediamo Millennium di Fincher, i film di Soderbergh, MI:4 di Bird, i Batman di Nolan, e altri megabudget fatti con la testa, scopriamo che siamo tornati a una narrazione fortissima, inglobante, persino sfibrante, con personaggi numerosi, e pesanti accumuli di avvenimenti, dentro congegno che sovente sfiorano le tre ore. Si narra meglio, si narra di più, sono saltati tutti i parametri estetici (discutere su quanto sia “di” Fincher il bellissimo Millennium è ozioso), c’è il pungolo delle serie tv che morde il grande schermo, e pare che tutti siano tornati a raccontare storie piene. Lo spiega anche Bruno Fornara su Cineforum n. 509 (nel book intitolato Le disavventure della narrazione), che però avverte: manca un largo strato di pellicole in grado di mandare il pubblico in sala tra un blockbuster e l’altro. Mancano, per intenderci, i thriller, le commedie, i noir, i mélo da medio budget che attirano lo spettatore al cinema. Oggi titoli come 40 carati o persino L’arte di vincere fanno incassi da cinema d’essai. La narrazione si potenzierà anche in quella fascia produttiva? O il blockbuster “col cervello” continuerà a rappresentare l’unico laboratorio americano possibile fuori dalla tv? Questa indicazioni valgono anche per il cinema europeo, e italiano in particolare. Senza effetti speciali e set da 100 milioni di dollari, si può pur sempre narrare, narrare, narrare. Costruire universi, spingere il pedale dell’invenzione, intensificare personaggi e azioni. Acab è un inizio in questa direzione. Vale la pena rifletterci: non si vive di sola commedia.
Se vediamo Millennium di Fincher, i film di Soderbergh, MI:4 di Bird, i Batman di Nolan, e altri megabudget fatti con la testa, scopriamo che siamo tornati a una narrazione fortissima, inglobante, persino sfibrante, con personaggi numerosi, e pesanti accumuli di avvenimenti, dentro congegno che sovente sfiorano le tre ore. Si narra meglio, si narra di più, sono saltati tutti i parametri estetici (discutere su quanto sia “di” Fincher il bellissimo Millennium è ozioso), c’è il pungolo delle serie tv che morde il grande schermo, e pare che tutti siano tornati a raccontare storie piene. Lo spiega anche Bruno Fornara su Cineforum n. 509 (nel book intitolato Le disavventure della narrazione), che però avverte: manca un largo strato di pellicole in grado di mandare il pubblico in sala tra un blockbuster e l’altro. Mancano, per intenderci, i thriller, le commedie, i noir, i mélo da medio budget che attirano lo spettatore al cinema. Oggi titoli come 40 carati o persino L’arte di vincere fanno incassi da cinema d’essai. La narrazione si potenzierà anche in quella fascia produttiva? O il blockbuster “col cervello” continuerà a rappresentare l’unico laboratorio americano possibile fuori dalla tv? Questa indicazioni valgono anche per il cinema europeo, e italiano in particolare. Senza effetti speciali e set da 100 milioni di dollari, si può pur sempre narrare, narrare, narrare. Costruire universi, spingere il pedale dell’invenzione, intensificare personaggi e azioni. Acab è un inizio in questa direzione. Vale la pena rifletterci: non si vive di sola commedia.